- Programmi
- Visite
- Salute A-Z
-
Chi siamo
-
Medici
-
Aziende
- Indietro
- Magazine salute
- L’esperto risponde
- Indietro
- Farmaceutiche
- Welfare
- Assicurazioni
- Indietro
- MMG/PLS
- Specialisti
- Indietro
- La nostra storia
- Team
- Blog
- Certificazioni
- Newsletter
- Careers
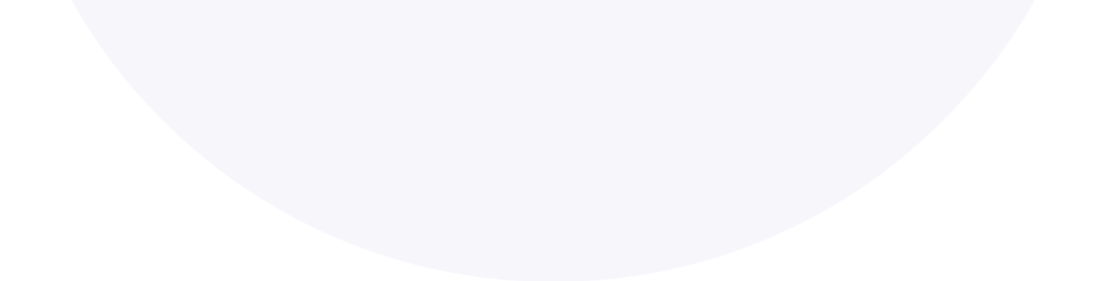
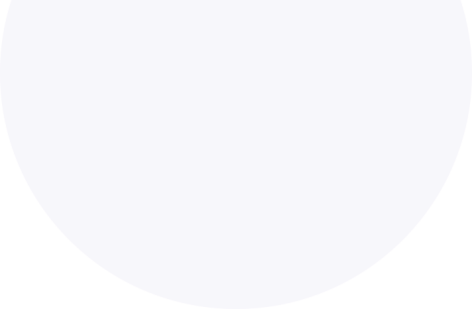
Esperto Risponde
rispondo alla giusta esigenza di rispetto
scrivo in relazione alla mia domanda 451U3FE3QH. resto basita davanti alla risposta del dott. tripeni, palesemente non ha capito il problema. io di problemi non ne ho, non ho sensi di colpa e non sono una psicopatica. sono solo una mamma che ama e rispetta immensamente i suoi figli, che cerca di fare tutto quel che può per dare il meglio di se per i suoi piccoli. è ovvio che il sostegno del papà e delle altre figure di accudimento (familiari e scolastiche) non manca, nè tantomeno ho mai detto di volere modellare mio figlio su standard da adulto per soddisfare il mio ego che vuole la famiglia del mulino bianco. mio figlio ha risolto da diversi mesi i suoi problemi di udito ed ora è il momento di occuparsi di alcuni aspetti che preoccupano per la possibilità di inficiare la vita relazione e la fase di apprendimento pre-scolastico del bimbo.mi sembra molto diverso. mi sembra che cercare di fare del proprio meglio per sostenere i figli non sia indice di problemi psicologici della mamma, anzi! la risposta superficiale dovrebbe anzi fare riflettere il dott. tripeni molto attentamente. ogni mamma, anche la migliore, perde a volte la pazienza ..non è un mostro che ha bisogno di assistenza psicologica, ma chi sente fischi e risponde fiaschi, forse dovrebbe un attimo leggere bene prima di fare figuracce simili
Risposta del medico
Ho riletto con attenzione il quesito e con altrettanto scrupolo la mia risposta. La signora ha chiesto un consiglio ("le chiedo qualche consiglio”) e ho fornito, con molta umiltà e coscienza, un mio parere ("leggo il suo quesito con molta inquietudine, innanzitutto perché mi rendo conto di non esserle di fronte per approfondire meglio la sua richiesta e il senso delle sue preoccupazioni”) tenendo conto dei limiti oggettivi di questo tipo di consultazioni.
Convinto che si tratti di una forma di consulenza fatta per sommi capi, limitata agli elementi sintetici forniti nella richiesta e, di conseguenza, trascurando molti particolari che potranno essere asseverati solo attraverso riscontri diretti, con l’uso di strumenti clinici adeguati.
Da parte mia, metto il bambino al centro della nostra attenzione e cerco di comprendere i suoi comportamenti; quelli che la madre annota, relativamente alle attività sociali del bambino, gli aspetti che possono preoccupare per la possibilità di inficiare la vita di relazione e la fase di apprendimento. Tengo in considerazione il comportamento del bambino perché mi chiedo cosa voglia esprimere in quel modo. Un clinico attento presta attenzione ai sintomi, s’interroga sul contenuto non verbale di quei messaggi, fa delle ipotesi … Non giudica. Fa delle osservazioni che, secondo i casi, devono essere confermate con gli strumenti adeguati (colloqui, test, visite specialistiche, ecc.).
Allo stesso tempo accolgo la richiesta di aiuto della madre (sto provando in tutti i modi … ma sembra non serva a nulla. Sia noi che le maestre siamo allo stremo”. “…non so più come aiutarlo e sostenerlo”.
Per questi motivi ho suggerito un “un sostegno psicologico che possa rappresentare per lei un’occasione per rispecchiarsi attraverso un/a professionista, innanzitutto in grado di “mettersi nei suoi panni”, che l’aiuti a ritrovare se stessa e il senso della maternità che passa obbligatoriamente nella responsabilizzazione ma anche nella cura della relazione genitoriale ed educativa. Affinché, aiutando se stessa, possa aiutare i suoi figli.” Tenendo presente, indiscutibilmente, che chi soffre non necessariamente è malato.
Tuttavia, con molto rammarico, noto che una mia affermazione espressa in forma retorica, in una maniera ormai di uso gergale (beh, questa è pura follia) per evidenziare con un’iperbole un modo sproporzionato di porsi nei confronti del problema, abbia offeso la signora.
Non è stata mia intenzione offenderla, tantomeno attribuire giudizi di valore (e mai ho avuto intenzione di esprimere nel corso della mia quarantennale attività professionale parole ingiuriose nei confronti dei miei clienti) tuttavia sono consapevole di avere utilizzato un termine che nello specifico contesto nel quale ci troviamo, ha generato un equivoco. Voglio scusarmene pubblicamente e chiedo alla signora di accogliere con benevolenza tali scuse.
Per quanto riguarda il resto, confermo le mie ipotesi di partenza.
Pur tenendo in evidenza il fatto che non conosco direttamente la madre, il bambino, il contesto familiare e sociale, ecc.; ritengo possibile, proporre un mio sensato punto di vista.
Risposto il: 05 Febbraio 2015



